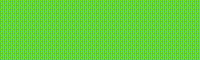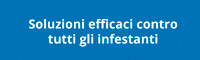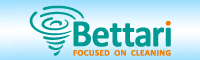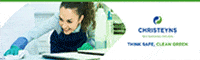La guerra infinita

Nelle strutture sanitarie, in particolare modo negli ospedali è sempre presente il rischio di contaminazione da microrganismi patogeni. Non bisogna mai abbassare la guardia per non incrementare il già alto tasso di IOS (Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie ) e ICA ( Infezioni Correlate alla Assistenza). La ricerca di soluzioni per le operazioni terminali di pulizia e disinfezione è sempre più attiva e ricca di proposte, che coinvolgono gli operatori sanitari di tutto il mondo. Un esercito agguerrito che combatte senza tregua.
“Primum non nocere” è una delle locuzioni del principio Ippocratico, il cui obiettivo è quello di non arrecare danno al paziente con il proprio operato. Principio che, però, si scontra con gli insuccessi legati alle azioni e con le conseguenze negative che le stesse possono generare. In questo senso, si inseriscono anche le Infezioni Correlate alla Assistenza (ICA ). La medicina, in tempi diversi, si è frequentemente imbattuta con questa evidenza e nel corso dei secoli molti sanitari e ricercatori hanno cercato e trovato soluzioni sempre più efficaci per contenere la problematica delle infezioni contratte in ambiente sanitario. Tra il 1600 e gli inizi del 1700, le osservazioni illustrate di William Petty e Alexander Monro sulla pulizia degli ambienti in cui i malati risiedevano e venivano operati hanno rappresentato il primo passo nel controllo delle ICA, anche se si devono attendere diversi anni, sino alla metà del 1800, per arrivare alle brillanti intuizioni di Ignàc Fulop Semmelweis, che introdusse l’utilizzo dell’acido fenico in ospedale. Va però ricordato, anche se pochi ne sono a conoscenza, che il primo vero utilizzatore di antisettici e disinfettanti in ambito ospedaliero, fu un italiano, Enrico Bottini, vissuto tra il 1835 e il 1903, primario ospedaliero a Novara, poi, dal 1877, direttore della clinica chirurgica di Pavia. Nel 1866 illustrò, prima dell’inglese J. Lister, pioniere della chirurgia antisettica, l’azione battericida dell’acido fenico. Da sempre, quindi, la pulizia e la sanificazione degli ambienti sanitari rivestono un ruolo importante, non solo per il significato che assumono nell’ambito del confort alberghiero, ma soprattutto per le implicazioni di ordine igienico-sanitario che influiscono sulla qualità delle cure erogate e sull’efficienza ed efficacia dell’organizzazione dei servizi. L’utilizzo di adeguate e innovative metodiche di pulizia e sanificazione concorre a diminuire la possibilità di diffusione dei microorganismi, e conseguentemente limita la propagazione delle infezioni, permettendo di migliorare la qualità della vita del paziente e degli operatori. Una delle questioni più controverse e dibattute è il ruolo qualitativo e quantitativo del contesto ambientale nel processo di contaminazione/colonizzazione del paziente, in particolare il ruolo delle superfici di confinamento e di arredo. Infatti, è noto che queste superfici agiscono come serbatoi per i microrganismi, aumentando il rischio di contaminazione attraverso il contatto diretto e/o indiretto con il paziente. È in questa logica che la ricerca e le aziende del settore, oltre agli addetti al controllo e prevenzione delle ICA, sono alla continua ricerca di nuove e innovative tecnologie di sanificazione/disinfezione. Non c’è dubbio che, rispetto al passato, gli ospedali siano realtà strutturalmente molto più articolate, con superfici che sono aumentate in modo esponenziale per l’introduzione di macchinari, di sistemi di monitoraggio e controllo, di carrelli attrezzati per i vari utilizzi, e di tutto quanto la moderna tecnologia mette al servizio della sanità. Ma, se da una parte la qualità dell’assistenza medica migliora e ha punte di eccellenza in ogni campo (tanto che, nonostante le polemiche su alcuni episodi di mala sanità, l’aspettativa di vita della popolazione italiana è molto alta grazie anche all’alto grado di efficienza del nostro sistema sanitario), dall’altra il successo clinico si accompagna a rischi potenziali, universalmente riconosciuti in crescita, di infezioni ospedaliere, dovute anche alle contaminazioni ambientali. Causa di rischi infettivi sono microrganismi come quelli indicati con l’acronimo MDROs (Multidrug-Resistant Organisms, divenuti resistenti a una o più molecole antibiotiche) quali, per esempio: Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus Meticillino-resistente (MRSA), Staphylococcus aureus vancomicina-resistente (VRE), Enterococchi (VRE), Clostridium difficile, E. coli, Enterobacter, Klebsiella appartenenti alla famiglia dei ceppi divenuti resistenti agli antibiotici del gruppo dei Carbapenemici, Norovirus. Questi batteri sono riconosciuti come patogeni ospedalieri e hanno una innata abilità a sopravvivere sulle superfici per lunghi periodi. Tuttavia, appropriate pratiche igieniche ne possono ridurre notevolmente la quantità; la diminuzione di contaminanti nell’ambiente ospedaliero è confermato da numerose evidenze ed è universalmente associato ad uno dei capo saldi delle misure di controllo e riduzione delle ICA. Varie sono le metodiche che vengono praticate, abitualmente o sperimentalmente, per diminuire la contaminazione ambientale, fatto salvo il principio di una preventiva detersione di tutte le superfici. Panni umidificati Tra le metodiche più utilizzate, c’è senza dubbio l’utilizzo di panni umidificati (wet wipes), che possono essere in cotone o in microfibra, mono o multiuso. Evidenze dovute a più situazioni, in ospedali di tutto il mondo, inducono a decretare la maggiore efficacia del panno in microfibra rispetto al panno in cotone. Come è ormai risaputo, le microfibre, dello spessore di un sedicesimo di un capello umano, sono costituite da una miscela di poliestere e poliammide, e sono strutturate in modo da trattenere polvere e sporco, agendo per capillarità: il poliestere ha potere elettrostatico e il poliammide potere assorbente. I panni in microfibra, quindi, possono “trattenere” i liquidi sino a sei volte il loro peso e catturare la polvere con maggiore efficacia dei tradizionali panni in cotone. I panni in microfibra hanno dimostrato la loro superiorità nella rimozione di diversi tipi di organismi - MRSA, Acinobacterìus Baumannii, Klebsiella oxytoca – da diverse tipologie di superfici, che vanno dal laminato plastico all’acciaio, dal vinile al linoleum, sia liscio che ruvido. La loro capacità di rimozione è stata valutata sia con piastre da contatto, sia con la misurazione della bioluminescenza della ATP. In ambedue i casi l’utilizzo di microfibre si è rivelato “importante” per la decontaminazione delle superfici, tuttavia rimangono alcuni aspetti da chiarire, come, per esempio la possibilità di “trasporto” dei batteri trattenuti dal panno, o se siano preferibili i panni monouso rispetto a quelli riutilizzabili, per limitarci al solo aspetto funzionale, senza tener conto dei maggiori o minori costi (aspetto peraltro importante per la nostra sanità pubblica). Panni in microfibra abbinati al vapore Sempre partendo dalla premessa imprescindibile che le operazioni di sanificazione non possono mai sostituire gli interventi quotidiani di pulizia, effettuati a regola d’arte, è interessante valutare l’efficacia dell’azione del vapore, erogato da apposite macchine, unita a quella dei panni in microfibra, soprattutto per la decontaminazione in situazioni di eccessiva proliferazione di agenti patogeni. Il sistema integrato, microfibra più vapore, sfrutta i “fondamentali” della pulizia/sanificazione: la temperatura del vapore, l’effetto meccanico del panno, il tempo di applicazione (che è ridotto rispetto a pratiche più tradizionali), eliminando, invece, i prodotti chimici, la cui azione viene effettuata dal potere detergente dell’acqua portata a temperature elevata (almeno 150° in uscita dal generatore di vapore). Il vapore, sulla base di numerose evidenze, svolge azione decontaminante, in quanto elimina gli effetti contaminanti di sostanze biologiche e chimiche da ambienti, attrezzature, macchine, superfici, e azione igienizzante e sanificante, in quanto abbatte la carica microbica e combatte la presenza di microrganismi patogeni (fondamentale per quanto riguarda attrezzature e impianti in ambienti ad alto tasso di frequentazione). Tuttavia, nonostante presenti aspetti interessanti (si sono osservati importanti abbattimenti di cariche microbiche), questa metodologia deve essere meglio definita per quanto riguarda il suo impatto sul controllo delle Infezioni Ospedaliere. In ogni caso, l’abbinamento Microfibra/Vapore può essere presa in considerazione, anche se alcune superfici ad alto rischio, come interruttori, computer, applicativi elettromedicali, possono presentare problemi di praticabilità da valutare. Perossido di Idrogeno In via di sperimentazione ci sono nuove metodologie, come quella che prevede l’utilizzo del Perossido di Idrogeno nebulizzato. Anche in questo caso si tratta di interventi che devono essere complementari alla detersione manuale, che, tuttavia, hanno il vantaggio di essere ripetibili, indipendentemente dall’affidabilità degli operatori (che, invece, deve essere massima nel caso di interventi manuali) per garantire la giusta distribuzione, il tempo di contatto, e via dicendo. La nebulizzazione, infatti, avviene tramite una apparecchiatura debitamente calibrata. Questa tecnologia aumenta la probabilità di una efficace riduzione di patogeni, mediante una distribuzione relativamente uniforme e capillare del disinfettante (il Perossido di Idrogeno) sulle superfici esposte. Il limite di questa tecnologia risiede nel fatto che l’attività del Perossido di idrogeno è ridotta in presenza di materiale organico, per cui è tassativo garantire una corretta sanificazione preliminare. Per ora, la letteratura di riferimento propone dati di efficacia nel controllo delle IOS/ICA solo per alcuni “sistemi”. Per quanto a oggi noto, le situazioni che più sono adatte all’applicazione di questa metodica sono quelle in cui il rischio e/o le conseguenze dell’infezione sono importanti, come le aree che hanno ospitato pazienti colonizzati o infetti (Clostridium difficile, Acinobacter baumannii, MDR in genere e Enterobacter KPC), o quelle in cui si verifichino epidemie dovute a microrganismi con elevata capacità di sopravvivenza all’ambiente. La luce Altra metodica cui si guarda con grande attenzione è quella che utilizza la luce, precisamente i raggi UV-C, ossia raggi ultravioletti con lunghezza d’onda compresa tra 100 e 280 nanometri, che hanno proprietà germicide. L’effetto germicida delle radiazioni UV-C si estende a batteri, virus, spore, funghi muffe e acari; esso è dovuto soprattutto all’effetto distruttivo esercitato dalle radiazioni UV-C sul loro DNA; tutto ciò contribuisce al danneggiamento del loro apparato riproduttivo impedendone la crescita e la moltiplicazione. Le spore sono resistenti a UV-C e, quindi, richiedono alte dosi di esposizione. Per l’erogazione dei raggi UV-C si possono utilizzare lampade a vapori di mercurio o a vapori di gas xenon. Le prime emettono radiazioni UV-C 254 nm (lunghezza d’onda di 254 nanometri) in modo continuo, e la dose letale si accumula gradualmente, in funzione della durata dell’esposizione e della distanza della lampada dalle superfici da decontaminare. Le seconde (PX-UV), emettono raggi UV-C 100.280 nm attraverso brevi impulsi ad alta intensità, e l’azione germicida ha effetto in un minore tempo di esposizione rispetto a UV-C, però l’efficacia è ridotta notevolmente dalla distanza della lampada dalle superfici interessate. Questa metodica si applica per il trattamento terminale dell’aria e delle superfici esposte, che deve avvenire in assenza di persone e dopo un’accurata detersione. Dopo il trattamento non si registra presenza di residui, tuttavia devono essere indagate eventuali conseguenze per operatori e pazienti se accidentalmente esposti all’irraggiamento. Sono efficaci su un ampio spettro di microrganismi, i tempi di esposizione sono rapidi ma variabili, in quanto dipendono dalle specie microbiche presenti e dal sistema che viene utilizzato. Non penetrano attraverso plastica e vetro e anche la penetrazione in acqua e tessuti è piuttosto debole. Inoltre, allo stato attuale, non è noto se il loro impiego diminuisca l’incidenza di infezioni ospedaliere. In sostanza, l’utilizzo di UV-C è semplice e ha cicli di azione relativamente brevi, che, però, devono essere ripetuti più volte all’interno del locale, variando la posizione della fonte di emissione, in quanto molti siti “a rischio contaminazione”, come le superfici dietro i mobili o comunque non libere, possono venire a trovarsi fuori dalla linea di luce. Anche la presenza di materiali che non riflettono UV-C o lo riflettono poco, così come le variazioni di temperatura e umidità o l’”età” del bulbo, possono influenzare la dose riflessa e aumentare il tempo di esposizione. L’intensità di UV-C diminuisce in proporzione alla lontananza dalla sorgente, pertanto il sistema è idoneo per locali di limitate dimensioni. Allo stato attuale, inoltre, non è ben descritto l’impatto sui materiali ospedalieri. In pratica… Oggi si stanno sperimentando anche altri sistemi, come l'utilizzo di luce ad alta intensità dello spettro visibile o l'impiego di materiali auto-sanificanti, tutti sistemi che, per gli interventi terminali, possono efficacemente sommarsi ai metodi tradizionali. Ma, citando F. Barbut, ricercatore dell'Università Pierre e Marie Curie di Parigi: "prima di implementare in un set clinico un metodo automatizzato, devono essere presi in considerazione vari aspetti: l'organizzazione ospedaliera, l'efficacia del sistema e la sua integrazione nei servizi ospedalieri, il costo globale dell'intervento, rispetto, per esempio, all'installazione, alla gestione, alla sicurezza, al rapporto costo/efficacia eccetera". Tenacia e sperimentazione unite alla massima cautela, in quanto l'imperativo di Ippocrate è tuttora imprescindibile.

Articolo precedente
L’Europa si attrezza per l’invasione delle cavallette
Articolo successivo
Strategia politica verde

Nessun commento